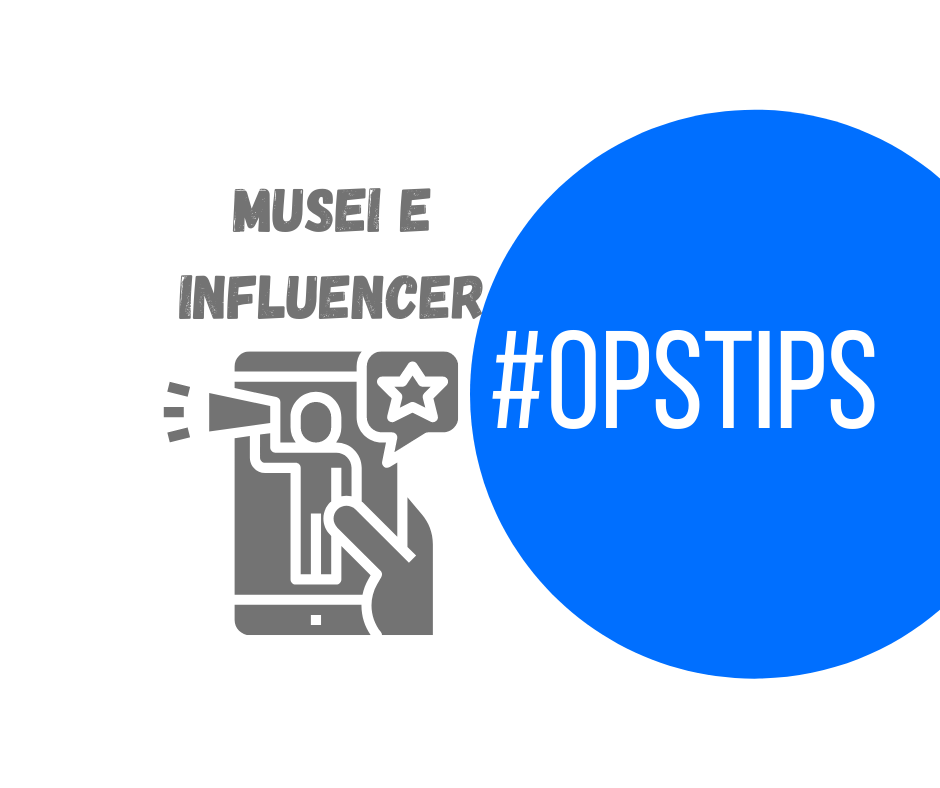Il mondo dell’arte e le grandi istituzioni museali si sono avvicinate alla comunicazione digitale, dopo la spinta propulsiva dovuta alle chiusure forzate per pandemia del 2020-21.
Il bisogno di comunicare con il proprio pubblico, di continuare a far sentire la presenza e la vicinanza emotiva con i visitatori, mantenendo alta la curiosità e la voglia di tornare, ha portato a fare un balzo in avanti nell’uso dei media digitali, moltiplicando le live di visite guidate, le visite virtuali, i contenuti condivisi sui social network.
Le istituzioni che avevano un passato già consolidato di comunicazione via social si sono spinte oltre e si sono avventurate nel settore dell’influencer marketing, considerando di poter rendere più appetibili mostre temporanee o visite alle collezioni permanenti.
Gli Uffizi non sono forse stati pionieri, ma sicuramente sono stati un caso eclatante, avendo potuto contare sulla presenza dell’influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni.
La Ferragni era al museo per uno shooting di moda, ma ha postato anche foto davanti alle opere, come una turista qualsiasi. Pur non essendo quindi un contenuto pensato appositamente per il museo, la sua visibilità è stata sufficiente per creare hype e innescare un meccanismo di emulazione.
È partita quindi una sorta di caccia all’influencer o al content creator, con la speranza di accattivarsi le attenzioni di un pubblico più giovane, ma non sempre con un progetto coerente con il resto del piano editoriale.
Il “caso” Palazzo Strozzi
Sta facendo scalpore il caso di Palazzo Strozzi a Firenze e della mostra su Donatello. Il museo ha ingaggiato tre creatori digitali, ma mentre i primi due (Wikipedro e Giovanni Arena) si sono concentrati sulla mostra, la terza, Maryna, ha ideato uno sketch comico (negli intenti) dove impersonava sia la guida saccente e snob che il visitatore coatto e ignorante.
La scelta di rappresentare in quel modo guide e operatori museali, ma soprattutto il potenziale pubblico, immaginato a priori rozzo e ignorante, non è sembrata particolarmente felice e molti professionisti del mondo della cultura e del mondo della comunicazione sono insorti.
In un primo momento Palazzo Strozzi ha lasciato la gestione dei commenti su Instagram all’influencer che, se possibile, ha peggiorato ulteriormente la situazione rispondendo in maniera sgarbata e sbeffeggiando i commentatori, ringraziandoli per tutta la visibilità che le stavano dando.
Il secondo intervento è stato eliminare i commenti più pungenti e preparare una risposta standard, che parlava della volontà di “raggiungere nuovi segmenti di pubblico”, da copiare e incollare sotto altri commenti meno aspri.
Un epic fail di comunicazione, sia in fase progettuale (la creator aveva carta bianca? Non c’è stata nessuna supervisione da parte dell’ente museale?) che in fase di gestione della crisi, dove si è assistito a un esempio concreto del modo di dire: “la toppa è peggio del buco”.
Influencer marketing
Il caso apre una riflessione interessante sull’influencer marketing. Il mondo della cultura dovrebbe imparare dal mondo della pubblicità, dove la scelta del “testimonial” ha da sempre avuto un’importanza centrale e nello stesso tempo ha subito un’evoluzione, comprendendo l’importanza della coerenza tra valori del brand e valori del personaggio famoso scelto per rappresentarlo.
Gli influencer hanno un margine creativo superiore, perché il loro messaggio è rivolto non a un pubblico generalista, ma a un pubblico di persone realmente interessate alla loro vita e al loro modo di raccontarla. Questo è sufficiente per poter affidare a loro la percezione di un prodotto/servizio/museo?
Nel caso specifico, siamo sicuri che il pubblico degli influencer possa davvero sovrapporsi a quello dei musei e delle istituzioni culturali? Nessuno potrà mai dare una risposta specifica, perché anche in questo caso l’approccio è stato approssimativo, non avendo previsto nessuna modalità di acquisizione dati.
Sarebbe bastato dare un codice sconto a ogni influencer/creator per vedere quanti visitatori avrebbero effettivamente portato al museo. Certo, la loro funzione è ispirare e non vendere il biglietto, per cui i followers potrebbero vedere il video, segnarsi mentalmente la destinazione come meta di un possibile weekend e andare fisicamente anche molti mesi dopo, ma sarebbe stata almeno una base oggettiva per costruire certi ragionamenti, che al momento sembrano basati su percezioni e vanity metrics (like, commenti, numero visualizzazioni.)ROI, ritorno sull’investimento? Non pervenuto…